 Per noi che abitiamo nella terra in cui lo street food è stato elevato a simbolo sociale del saper vivere, siamo ormai così esperti di come il Prodotto Tipico possa magicamente tramutarsi in Inculata Fotonica che la prospettiva di partecipare all’ennesima festa giapponese senza ramen, sagra pugliese senza orecchiette, truck food festival con prezzi dai 15€ in su ci lusinga come un temporale in montagna. Soprattutto se l’idea di base è quella di alzarsi alle 6:30 di sabato mattina e fare 500 km in un giorno fra andata e ritorno per ritrovarsi in un borgo dimenticato da Dio dove dovrai pagare 12 gettoni (i quali, in virtù di una conversione mistica che ti lascerà alla fine della giornata con X gettoni d’avanzo che non ti basteranno nemmeno per l’acqua, corrispondono a circa 375€) anche per garantirti l’ingresso in un bagno chimico.
Per noi che abitiamo nella terra in cui lo street food è stato elevato a simbolo sociale del saper vivere, siamo ormai così esperti di come il Prodotto Tipico possa magicamente tramutarsi in Inculata Fotonica che la prospettiva di partecipare all’ennesima festa giapponese senza ramen, sagra pugliese senza orecchiette, truck food festival con prezzi dai 15€ in su ci lusinga come un temporale in montagna. Soprattutto se l’idea di base è quella di alzarsi alle 6:30 di sabato mattina e fare 500 km in un giorno fra andata e ritorno per ritrovarsi in un borgo dimenticato da Dio dove dovrai pagare 12 gettoni (i quali, in virtù di una conversione mistica che ti lascerà alla fine della giornata con X gettoni d’avanzo che non ti basteranno nemmeno per l’acqua, corrispondono a circa 375€) anche per garantirti l’ingresso in un bagno chimico.
In questo caso la fortuna – o la divinità protettrice dei martiri dello street food – è stata dalla nostra parte. Essa si è manifestata per la prima volta a metà strada, all’altezza di Affi (VR), sotto forma di una brioche vegana particolarmente buona e si è fatta strada con noi fra le montagne come una lama di luce che ci ha tenuto calde le scapole per tutta la giornata. Dopo altri 120 km siamo dunque arrivati nel regno delle mele senza incidenti di percorso né rimpianti. E proprio le mele sono il pretesto attorno a cui ruota attorno Pomaria, la nostra meta del giorno: un festival itinerante (nel senso che il borgo che lo ospita è, a turno, uno fra quelli della Val di Non) giunto quest’anno alla sua 15^ edizione all’insaputa di tutti. O perlomeno a insaputa mia.
Cos’è Pomaria?
 Pomaria rappresenta tutto ciò che una sagra dovrebbe essere e raramente è. Un’occasione in cui non ci si limita a esibire su un piedistallo i prodotti del territorio senza spiegarli al consumatore, convinti che la loro semplice esistenza sia sufficientemente autoesplicativa (un po’ come la Gioconda nella sua stanza bianca dentro al Louvre), ma ci si prende del tempo per raccontargli cosa c’è dietro: una storia fatta di sacrifici, passione e soprattutto ricerca instancabile. Ricerca tecnologica, per produrre in maniera più sostenibile; ricerca scientifica, per ripristinare la biodiversità distrutta dalla mano dell’uomo; ma anche inventiva pura e semplice, quell’inventiva necessaria per escogitare nuovi formati che intrighino il consumatore e mantengano viva la sua attenzione.
Pomaria rappresenta tutto ciò che una sagra dovrebbe essere e raramente è. Un’occasione in cui non ci si limita a esibire su un piedistallo i prodotti del territorio senza spiegarli al consumatore, convinti che la loro semplice esistenza sia sufficientemente autoesplicativa (un po’ come la Gioconda nella sua stanza bianca dentro al Louvre), ma ci si prende del tempo per raccontargli cosa c’è dietro: una storia fatta di sacrifici, passione e soprattutto ricerca instancabile. Ricerca tecnologica, per produrre in maniera più sostenibile; ricerca scientifica, per ripristinare la biodiversità distrutta dalla mano dell’uomo; ma anche inventiva pura e semplice, quell’inventiva necessaria per escogitare nuovi formati che intrighino il consumatore e mantengano viva la sua attenzione.
 E così c’è ad esempio chi, come i Vivai Omezzoli, da oltre 50 anni prova a recuperare le specie antiche di mele, contrastando quell’impoverimento creato dal consumo di massa che vorrebbe metterci fra le mani soltanto mele Stark e Renette pastose e insipide, e studia come sviluppare la resistenza delle piante alle fitopatologie senza sottoporle a trattamenti, come conservarle senza l’uso di celle frigorifere e come valorizzarle dando loro un ruolo di spicco nella cultura di massa. La riscoperta della diversità, poi, fornisce una variegata materia prima con cui creare marmellate, composte e mostarde biologiche che hanno il sapore di qualcosa di antico e che il nostro corpo, con il suo implacabile istinto, riconosce come un alimento amico.
E così c’è ad esempio chi, come i Vivai Omezzoli, da oltre 50 anni prova a recuperare le specie antiche di mele, contrastando quell’impoverimento creato dal consumo di massa che vorrebbe metterci fra le mani soltanto mele Stark e Renette pastose e insipide, e studia come sviluppare la resistenza delle piante alle fitopatologie senza sottoporle a trattamenti, come conservarle senza l’uso di celle frigorifere e come valorizzarle dando loro un ruolo di spicco nella cultura di massa. La riscoperta della diversità, poi, fornisce una variegata materia prima con cui creare marmellate, composte e mostarde biologiche che hanno il sapore di qualcosa di antico e che il nostro corpo, con il suo implacabile istinto, riconosce come un alimento amico.
Ecologia e sostenibilità nel tempio delle mele
Si respira quasi un’aria sacrale, a Livo, durante Pomaria. C’è chi si assiepa attorno a un banco di formaggi a pasta cruda, fatti con il ricco latte delle brune alpine, ma i nugoli di cavallette si disperdono subito, non ci si pestano i piedi a vicenda, si procede in ordine per le vie di pietra accompagnando con un chiacchiericcio felice ogni assaggio fatto per strada, prezioso non per il prezzo, ma per il suo valore.

Si scoprono realtà come Aneghe Taneghe, azienda a conduzione familiare che produce carni di alta qualità allevando i propri animali nel rispetto delle loro necessità evolutive. Niente separazioni premature fra vitelli e vacche, niente mangime artificiale, ma soprattutto niente sprechi, perché dell’animale si usa ogni parte e i tagli vengono fatti solo su prenotazione.
Estranea a questi cieli è anche l’idea di farti pagare più del dovuto. E tu che vieni dall’alveare industrioso d’Italia, dove il bio e il chilometro zero diventano spesso più una scusa per spillarti soldi in più piuttosto che per promuovere davvero uno stile di vita più rispettoso della tua salute e dell’ambiente, trovarsi a pagare un prezzo onesto per buonissima farina di mais trentino o per un carnosissimo salmerino pescato secondo i princìpi della pesca biologica nei fiumi di questa regione sembra quasi un sogno. 
Anche le noci, qui, hanno un sapore completamente diverso e ti ritrovi ad addentare una treccia di pasta sfoglia con le narici invase da quella fragranza di bosco sperando che le noci californiane comprate alla Conad proprio il giorno prima potranno reggere il confronto quando le mangerai a colazione la mattina successiva. Spoiler: no, non lo reggono. Le noci del Trentino vincono a mani basse.
 Tutto questo girare fra banchi pieni di odori e di voci graziose, che ti incantano pronunciando “speck” con la “e” chiusa, non fa che accrescere l’appetito e arrivi all’ora di pranzo, che ora di pranzo non è perché sono solo le 12, che vorresti mangiare tutto. Ti prepari allora ad assestare un terribile colpo al tuo ottimismo, a veder la sopracitata dea protettrice dei martiri dello street food alzare le braccia in segno di resa e allontanarsi a capo chino: sei già preparato a dover affrontare chilometri di fila per un panino striminzito condito al ribasso. Invece la fila ti si volatilizza davanti e in quattro e quattr’otto sei libero di sederti su una panca a mangiare in un piatto di porcellana con posate vere – così si limita la plastica – , respirando la resina degli abeti intorno senza essere disturbato da tragedie greche di gente stressata che trova la propria autorealizzazione nel rubare il posto a qualcun altro.
Tutto questo girare fra banchi pieni di odori e di voci graziose, che ti incantano pronunciando “speck” con la “e” chiusa, non fa che accrescere l’appetito e arrivi all’ora di pranzo, che ora di pranzo non è perché sono solo le 12, che vorresti mangiare tutto. Ti prepari allora ad assestare un terribile colpo al tuo ottimismo, a veder la sopracitata dea protettrice dei martiri dello street food alzare le braccia in segno di resa e allontanarsi a capo chino: sei già preparato a dover affrontare chilometri di fila per un panino striminzito condito al ribasso. Invece la fila ti si volatilizza davanti e in quattro e quattr’otto sei libero di sederti su una panca a mangiare in un piatto di porcellana con posate vere – così si limita la plastica – , respirando la resina degli abeti intorno senza essere disturbato da tragedie greche di gente stressata che trova la propria autorealizzazione nel rubare il posto a qualcun altro.

Il menu prevede scelte carnivore e non, preparate e impiattate al momento, senza quel retrogusto di mensa che le pietanze lasciate scuocere in fondo a un pentolone hanno in genere nelle sagre paesane, soprattutto se molto frequentate. Späzle, canederli, polenta e tortel di patate si salutano a vicenda dai piatti allineati sulla stessa tavolata, mentre i bambini, disinnescati dalle altalene, isolano le loro grida in un’isola felice senza avanzare la pretesa di giocare con uno smartphone.
Non può mancare una birra, perché l’aria di montagna lo chiede, tanto più che splende il sole, e Pomaria non delude nemmeno sotto il punto di vista brassicolo. Il problema è semmai scegliere fra un banco e un altro, ma alla fine opti per il Birrificio Km8 di Contà, dato che BirraFon già la conosci e la apprezzi. Provi una black IPA, una APA, una Pils al sambuco: promosse tutte a pieni voti, oh, ma come è possibile che non abbiano fatto cilecca nemmeno una volta? E quando il proprietario dello stand ti saluta, incrociandoti da un’altra parte, ti senti come in quei paesini dove tutti conoscono tutti e nessuno lesina mai un “buongiorno”, ti senti accolto, non sei più un visitatore ma una parte del tutto.


A questo punto è il momento di fare compere: tutti portano a casa cassette di mele da almeno 4 kg; c’è chi comprerà formaggi, chi riempirà lo zaino di canederli allo speck e al formaggio, chi invece riporterà a casa miniporzioni di Sacher, in barba agli austriaci che sanno solo mettersi in fila dal lato giusto, ma poi, quando si tratta di dedicarsi alla sacra arte della pasticceria, vengono superati dai trentini con il dito medio alzato in corsia d’emergenza.
Il post pranzo: escursione al lago di Tovel dopo Pomaria
Arrivato il momento della digestione, sembra una buona idea affrontare i 40 minuti di macchina che ci separano dal lago di Tovel. Potrebbe non sembrarlo a chi soffre il mal d’auto (io) o a cui 10€ per il parcheggio sembrano un furto (ancora io), però poi il panorama di questa gemma alpina conquista anche i cuori più stanchi (sempre io, ma con il trucco sbavato e i capelli da Bellatrix Lestrange). Il lago di Tovel è ufficialmente diventato un mio luogo del cuore, credo che la visione delle sue acque di mille blu diversi potrebbe ripristinare la mia fiducia nella vita anche nei momenti più critici. Secondo me – e potete liberamente insultarmi per questa mia opinione – il fatto che le sue acque non si tingano più di rosso non è una perdita così sconvolgente, perché i colori di adesso fanno male al cuore da quanto sono belli. Ognuno di noi dovrebbe avere una stanza tutta per sé dipinta in queste tonalità.
Ma perché le acque di Tovel un tempo erano rosse? Narra la leggenda che la ferma volontà di Tresenga, principessa di Ragoli, di non sposare Lavinto, re di Tuenno, interessato più alle sue terre che alla sua persona, sfociò in una terribile battaglia sulle rive del lago che portò allo sterminio dei ragolesi. Il lago avrebbe così continuato a tingersi di rosso, ogni estate a venire, in ricordo dell’impavida e sfortunata Tresenga. In realtà quel colore è dovuto a un’alga che prima viveva sul fondale del lago e che poi si è estinta in seguito alle modifiche intervenute nell’ambiente, ma possiamo anche ipotizzare che lo spirito di Tresenga abbia finalmente raggiunto la pace e abbia ridato al lago di Tovel il suo aspetto originario. Peccato aver mancato di un paio di settimane la vera e propria esplosione di rossi e arancioni dell’autunno, ma anche così, e a dirla tutta anche in piena estate, questo posto è una cartolina vivente. Ed è forse proprio grazie al parcheggio a 10€ e alla navetta che si è costretti a prendere lasciando la propria macchina in balia delle guardie forestali che si riesce a mantenere intatto questo splendido ecosistema ancora nel 2019. Sperando che lo scioglimento dei ghiacciai non se lo porti via.







Per chi fosse interessato a visitare il lago di Tovel in estate, faccio presente l’esistenza di una realtà meravigliosa che risponde al nome di Malga Tuena: un piccolo paradiso arroccato fra le montagne che circondano il lago di Tovel, raggiungibile con circa un’ora e mezzo di passeggiata semi-verticale durante la quale avrete la possibilità di espiare tutti i vostri peccati, temere per la vostra vita al calar del sole e odiare voi stessi in maniera viscerale qualora vi siate scordati di portarvi dietro le bacchette (tratto da una storia vera).
In compenso, una volta che sarete arrivati lassù non vorrete più tornare indietro e capirete subito per quale motivo un mucchio di universitari, facendo una scelta così controcorrente rispetto alla propria generazione, dedichi ogni anno 4 mesi della propria vita ad allevare animali, coltivare terreni difficili e offrire ai viandanti un pasto caldo e un letto dove dormire lungo la via. Tutte le materie prime utilizzate dai ragazzi della Malga Tuena, se non direttamente prodotte da loro, provengono da coltivazioni biodinamiche trentine e da realtà artigianali del territorio come appunto la BirraFon già citata, che ho conosciuto grazie a loro. La polenta che ho mangiato qui me la sogno ancora di notte: il segreto, mi disse una delle ragazze della malga, è il burro; non quanto burro, ma quale burro.
Passate una notte qui e aiutateli in questo progetto meraviglioso, si meritano tutta la fortuna del mondo.



Laureata magistrale in Lingua e cultura italiane per stranieri all’università di Bologna, insegno lingue straniere nella scuola secondaria, ma ho lavorato per diversi anni nel settore del web marketing. Sogno una casa in collina e un cuoco giapponese privato. Amo i gatti, soprattutto quelli sfigatelli, e le Guzzi.
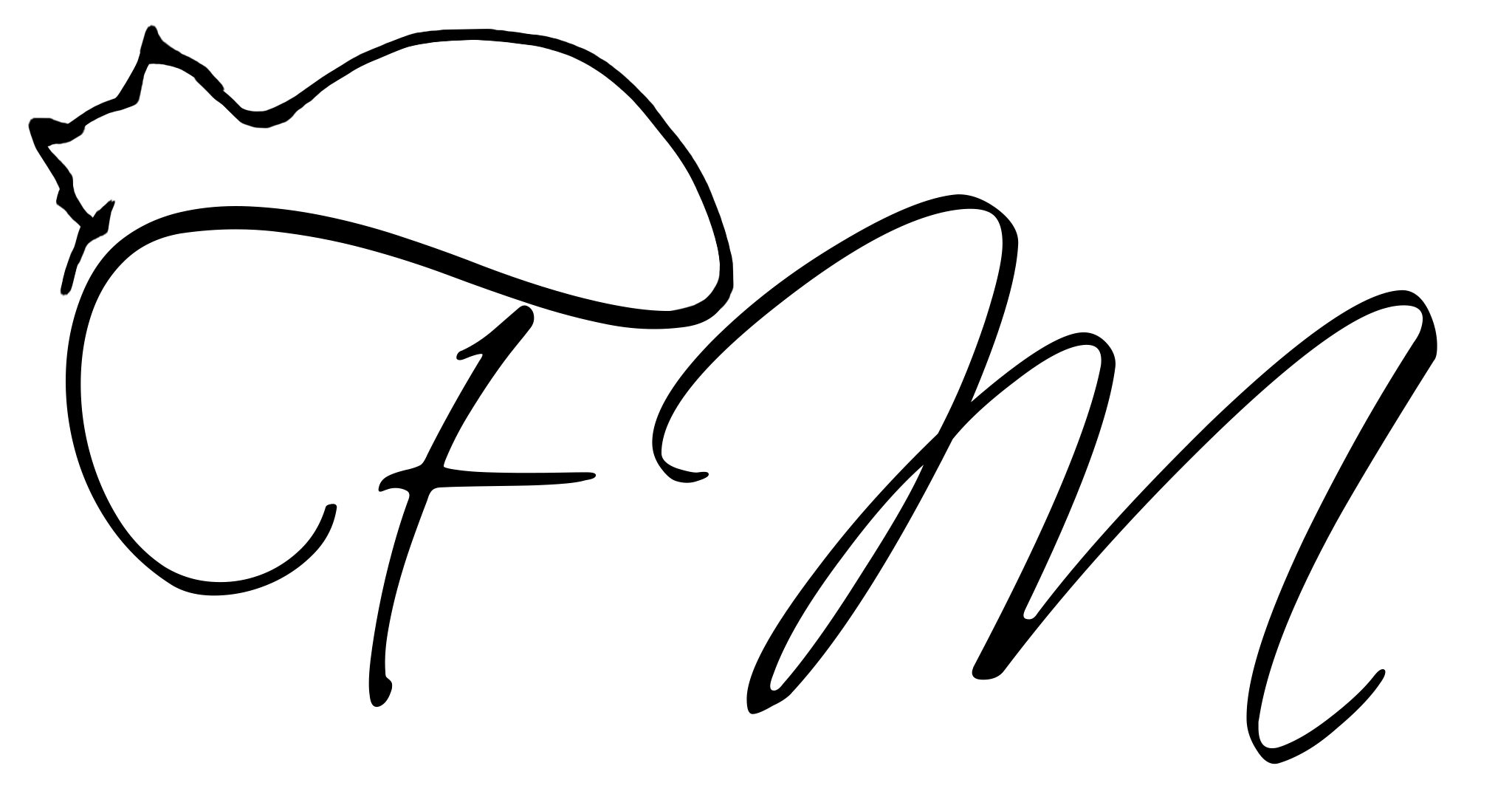
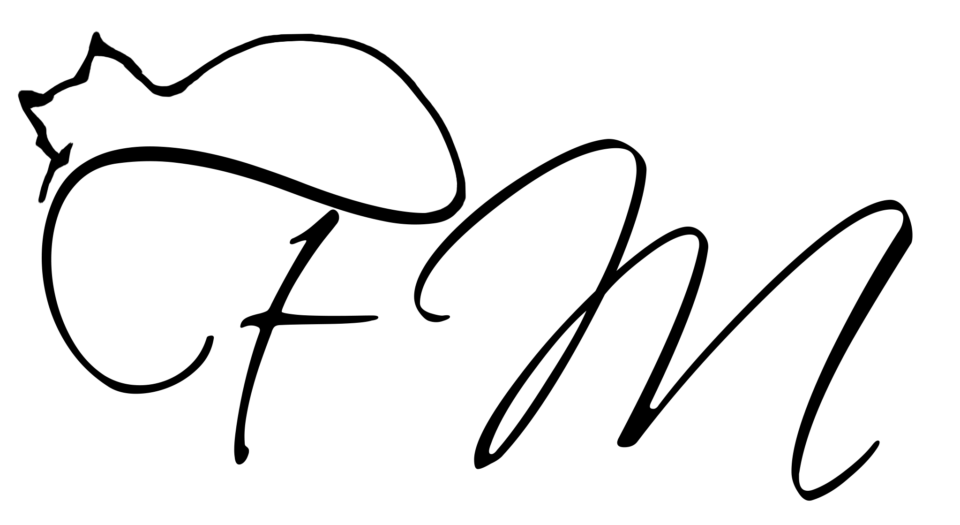

Pingback:Si stava meglio quando si stava 56k | Francesca Mondani